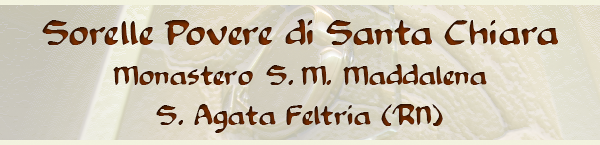
Parola della Domenica

22 Febbraio 2026 -
1 Domenica di Quaresima - A
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Se sei il Figlio...
In questa prima domenica di Quaresima che dà inizio ad un nuovo tempo liturgico abbiamo ascoltato un brano Evangelico che ci “scuote” sempre un po’: le tentazioni di Gesù nel deserto. Questo passo Evangelico ci scuote perché in fondo ci chiediamo: “ma il Figlio di Dio può veramente essere tentato come lo siamo noi?” Sotto questa domanda c’è forse un’idea difficile da smascherare, ma molto radicata nella nostra esperienza: “se Dio fosse davvero onnipotente non avrebbe permesso a Satana di mettere alla prova suo Figlio”. Qualcosa dentro di noi stride: “Se Dio è onnipotente, perché la guerra? La sofferenza? La morte?”. Queste domande, diciamolo, spesso ci abitano il cuore. Sono scandalose, ma anche profondamente umane. Queste domande, se le guardiamo bene, non sono molto diverse da quelle che pone il tentatore nel Vangelo di oggi. Sono domande umane, ma più radicalmente sono domande “diaboliche”. Non nel senso di “malvage” o sataniche, ma nel senso più profondo a cui rimanda la parola “diavolo”, ossia la divisione violenta. Queste domande sono “divisorie”, tentano di dividere, di separare, l’uomo da Dio; li allontanano creando tra i due una distanza che sembra incolmabile. Se leggiamo sotto questa lente le tentazioni, una cosa ci colpisce nelle parole del “divisore”: egli confonde continuamente lo sguardo che l’uomo ha su sé stesso e quello che ha Dio su di lui. Due degli interventi con cui il divisore interpella Gesù iniziano così: “se sei il Figlio di Dio...”(Mt 4,3 e Mt 4,6), ma in verità, il contenuto di questi interventi vogliono persuadere Gesù ad essere considerato “importante” agli occhi degli uomini, non ad essere consapevole della sua preziosità agli occhi di Dio. Trasformare le pietre in pane così da possedere risorse infinite, gettarsi dal punto più alto del tempio per dimostrare di essere immortale, conquistare tutti i regni del mondo a qualsiasi prezzo: è tutto ciò che vuole un uomo che desidera essere visibile, potente, riconoscibile e riconosciuto agli occhi degli altri. Ma tutto questo non ha nulla a che fare con lo sguardo di Dio, con uno sguardo che non ci vuole né padroni, né schiavi, ma ci vuole semplicemente figli. Quello che avviene in questo racconto è la scoperta che un vero figlio di Dio non si riconosce dalla sua onnipotenza, ma dal luogo interiore che abita: sotto lo sguardo di Dio? O sotto gli occhi del mondo?
Le risposte che Gesù dà al divisore, toccano il cuore di questa scoperta perché, se guardiamo con attenzione, sono tutte risposte “relazionali”. Gesù non mette al centro sé stesso o ciò che può fare o non fare da Figlio di Dio, piuttosto mette al centro la relazione stessa con Dio. La prima risposta ci dà già un’idea precisa: “l’uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4). Già di per sé un Dio che parla è un Dio che sceglie di mettersi in relazione. Cos’è la parola se non un modo in cui si comunica? Uno dei modi più immediati di relazionarsi ad un altro? Gesù dicendo che l’uomo non vive solo di pane, ma delle parole che escono dalla bocca di Dio, ci sta dicendo che a l’uomo non basta possedere qualcosa (fosse anche qualcosa di vitale): l’uomo vive della relazione con il suo Dio. La seconda risposta di Gesù ci dà un’altra sfumatura: “non metterai alla prova il Signore Dio tuo” (Mt 4,7). Questa risposta dice fondamentalmente una cosa: il Dio di Gesù Cristo è un Dio davanti al quale non dobbiamo dimostrare nulla. Gesù non si butta dal punto più alto del tempio. Il “fermarsi” di Gesù non è governato dalla paura che Dio non lo verrebbe a salvare, anzi, proprio perché si fida del Padre ed è certo che Egli vuole salvi i suoi figli, non sente alcun bisogno di “gettarsi giù”, non sente alcun bisogno di mettere alla prova questa relazione. L'ultima risposta è ancora più esplicita. Alla richiesta di Santa di adorarlo in cambio dei regni del mondo e della gloria, Gesù riporta l’attenzione su Dio: “Adorerai il Signore Dio tuo, e a lui solo renderai culto” (Mt 4,10). “Adorare” e “rendere culto” sono due azioni tipiche della preghiera e la preghiera è proprio il modo che l’uomo conosce per entrare in relazione col suo Signore. Questa relazione non si può “comprare”, questa relazione non ha prezzo, vale più di tutti i regni del mondo. Il divisore insinuando il dubbio, “se sei il Figlio di Dio...”, tratta Gesù da schiavo, gli vuole far credere che la sua relazione col Padre è mercificabile, che la nostra relazione con Dio è un “dare per avere”: pane in cambio della vita, fiducia in cambio di salvezza, preghiera in cambio di potere. Ma noi, sembra dirci Gesù nel Vangelo di oggi, siamo figli, non schiavi! L’amore di Dio che è nostro Padre è gratuito. L’episodio delle Tentazioni ci parla in fondo di un nuovo “Esodo”, del passaggio obbligato nel deserto che ciascuno di noi sperimenta qualche volta nella vita. E in questo deserto scopriamo che a nutrirci non è il pane, perché la vera manna è un Dio che ci rivolge la parola. Scopriamo che Dio non è quello che ci impedisce di cadere, ma quello che cade insieme a noi senza paura e poi, pazientemente, ci tende la mano per rialzarci. Scopriamo che Dio non è un bel vitello d’oro freddo e immobile, ma un Padre che ci scalda nel Suo abbraccio. Questa è, in definitiva, l’esperienza che Gesù fa attraversando il Suo deserto: un Dio che nel deserto si fa vicino. Il nostro racconto si conclude così: “Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano” (Mt 4,11). Il divisore lascia Gesù e gli angeli (che in tutta la Scrittura dicono la presenza di Dio) si avvicinano. Gesù allontanando da sé colui che voleva creare distanza tra l’uomo e il Signore, si scopre circondato dalla presenza di Dio. Un Dio che si avvicina a noi, un Dio che non esige di essere servito, ma che serve.
Ogni volta che smascheriamo ciò che veramente ci divide da Dio, scopriamo che Dio era già lì, più vicino di quanto pensassimo.











